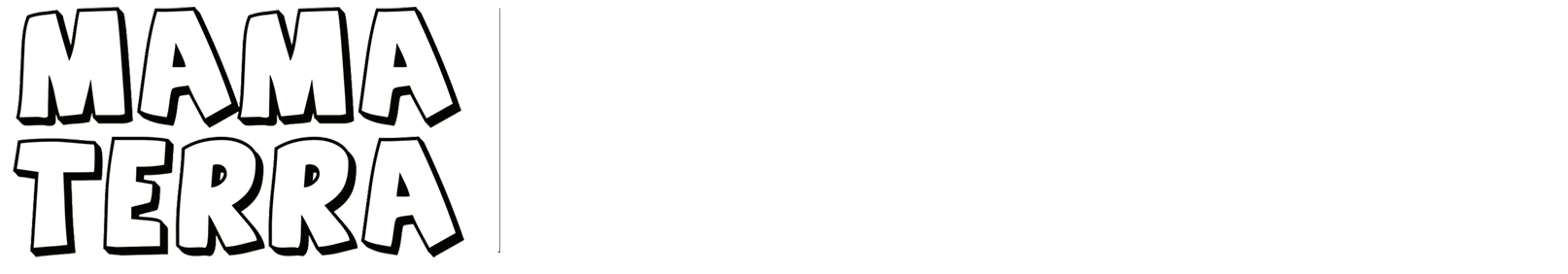Le madri dovrebbero difendere i semi come fossero i loro stessi figli.
Ma come si fa a pensare che ora sia necessario difendere il diritto al cibo? Siamo arrivati a questo? Ci stanno negando il diritto alla coltivazione di frutta ed ortaggi, così com’è sempre avvenuta, conservando forti ed antichi semi, di stagione in stagione? Come si fa a pensare che le grandi multinazionali delle sementi stiano modificando il genoma di grano e mais per nobili scopi? Imponendo un copyright alle migliaia di semi che modificano? Facendoci comprare i semi di stagione in stagione, che le loro modifiche rendono sterili? E completamente dipendenti da pesticidi e fertilizzanti? (Si veda il tragico esempio della soya Roundup-free e Roundup ready e la diffusione del Glifosate nelle campagne di tutto il mondo).
Come predicatori, nuovi coloni, questi spregiudicati assassini tentano di colonizzarci ancora una volta. Depredare il nostro patrimonio di semi tradizionali, acclimatati al nostro suolo, al ritmo delle nostre stagioni. Bisognerebbe introdurli nelle liste dei prossimi condannati per crimini contro l’umanità dai tribunali internazionali o nazionali in accordo con la definizione di crimini contro l’umanità data dall’ONU e/o dalla Corte Penale Internazionale…se solo a capo di queste istituzioni non vi siano gli stessi interessi, lo stesso delittuoso potere.
Le leggi regionali in difesa della biodiversità hanno iniziato a proporre ovunque il rilascio dei semi antichi, la loro mappatura. La scusa utilizzata è la loro conservazione in banche cosiddette ex situ, gli obitori costituiti dalle banche del seme delle nostre università – infatti queste banche, se non iniziano a fare un lavoro di ridistribuzione dei semi nel territorio, non son altro che dei macabri obitori.
Ma chiunque sia venuto a contatto con la vita contadina sa che questo non è possibile. I semi sono vivi, in continua evoluzione, si trasformano di anno in anno, si adattano. Se vengono spostati di campo possono variare di colore e forma, in base alle condizioni del suolo, all’abbondanza o no di acqua. Qualsiasi contadino, in fase empirica, conosce la ricchezza proposta dalla natura, senza alcun bisogno di una laurea in genetica, senza studiare biotecnologia o agronomia. Sa che il posto migliore per costruire una banca del seme è una rete viva, fatta di contatti umani, di nomi, di silenzi di campi, di migliaia di varietà coltivate in situ, nelle piccole aziende contadine o negli orti familiari.
Un tempo in Sardegna la donna riceveva i semi in dote, dai suoi genitori. Li portava con se, nella sua nuova casa, e con quella dote, su quella ricchezza, si basava una nuova famiglia.
Le terre comuni erano condivise e la popolazione poteva far pascolare il bestiame e raccogliere l’incolto. La terra ed i semi erano bene comune, proprietà collettiva. I nostri antenati intuirono che la privatizzazione delle terre comuni sarebbe equivalsa ad un furto. La terra offriva erbe edibili di pregio gastronomico, erbe officinali di infallibile efficacia erboristica e medica. Le erbe erano necessario sostegno alla salute umana. Ed una incredibile varietà di semi, che venivano scambiati e regalati e la loro circolazione e diffusione era regolata dalle leggi dell’”economia del dono”.
Dunque oggi, grazie all’azione dei nostri antenati, arrivata fino a noi malgrado il tentativo di rimozione della nostra storia, riconosciamo le leggi sulle sementi come un furto, come un oltraggio.
I padri dovrebbero difendere i semi, come ieri hanno difeso la terra. Le madri dovrebbero difendere i semi come fossero i loro stessi figli. In tutto il mondo, dall’India al Brasile, movimenti di donne e di uomini marciano per il diritto alla libera circolazione dei semi. Il movimento Navdanya (“nove semi”, le nove colture più importanti dell’India) fondato da Vandana Shiva e il movimento Sem Terra denunciano le brutali conseguenze della “rivoluzione verde”, dei fertilizzanti e delle varietà selezionate di semi: la resa è aumentata insieme alle estensioni coltivate a monocoltura. Perciò denunciano anche la scomparsa della biodiversità di quei campi, il degrado del suolo e delle acque, le espropriazioni “facili”, le terre pagate un tozzo di pane. Ne sono vittime prima di tutto le donne, le cui antiche pratiche sono meno produttive ma più rispettose degli ecosistemi. Dove infatti l’uomo si dedica alla pastorizia, vi è una donna nei campi.
Questi temi ci paiono lontani, mentre trascorriamo le nostre vite tra casa ed ufficio. E mentre mangiamo, due, tre, quattro volte al giorno, non chiedendoci più da dove arrivi il nostro cibo. Mentre, differenziando la carta dalla plastica pensiamo di essere dei grandi attivisti ecologici. Nelle città siamo completamente tagliati fuori dalla filiera alimentare. E tentiamo di compiere timidi passi di collegamento con le aziende circostanti e nuovi e vecchi contadini.
Stiamo, con lentezza, ritornando alla consapevolezza dell’importanza di produrre il cibo che consumiamo, o almeno, l’importanza di conoscere da dove proviene ed in che modo viene coltivato od allevato. Questo è il grido delle donne indiane, delle donne brasiliane, delle donne africane delle Gree Belt, dei giovani studenti di San Francisco pionieri dei progetti di agricoltura urbana. Il grido dei nostri antenati che hanno difeso la terra e il grido di tutti i contadini del mondo, malgrado il tentativo di “invisibilità costruita ad arte, ampiamente rafforzata dalla connotazione negativa che il termine contadino (o pastore) ha nel linguaggio quotidiano. Esiste una realtà empirica in cui ci sono molti più contadini di quanti ne siano esistiti in passato. Oggi nel mondo ci sono circa 1,2 miliardi di piccole e medie aziende contadine (Ecologiste 2004), e «i componenti delle famiglie contadine rappresentano, dopotutto, ancora circa i 2/5 dell’umanità. (Weis 2007, p.25)» (Van der Ploeg, 2008).
Andiamo a scoprirli nelle zone in cui viviamo, sosteniamoli, compriamo i loro prodotti, prendiamo accordi con loro, per comprare la loro verdura, la loro frutta, i loro formaggi e i prodotti animali.
Incoraggiamoli a piantare semi locali, a riattivare quella banca del seme, viva, che è l’unica ipotizzabile. Non nelle università, in cui i semi, son ricoverati come in un obitorio. Una banca viva, fatta di reti umane, di sostegno, di solidarietà. Perché l’unica possibilità di custodire i semi è tenendoli vivi nei piccoli territori a cui appartengono.
Le leggi stanno cambiando veloci ed a breve dovremmo difendere i semi sardi, come i nostri antenati hanno tentato di difendere la terra. Tentiamo di essere attivisti in questa stagione di ennesimi soprusi e di lottare per la diversità, per la vita e per la loro gratuità, ancora una volta.
Forse cent’anni fa era più facile. La plastica…non c’era. Il problema dell’esaurimento delle energie non rinnovabili…non c’era. E ancora non c’era la mafia delle pale eoliche, la monocoltura dei pannelli solari e quella di cardo per le biomasse, la minaccia dei gasdotti, i residui del polo petrolchimico nascosti nel sottosuolo, le basi militari che diffondono morte all’uranio; e la falsa ideologia che afferma che senza le monocolture non ci sarebbe cibo a sufficienza per tutti.
A volte può mancare la speranza, la ragione di lottare.
Ma davanti alla forza della natura, all’abbondanza degli orti, alla generosità dei semi della terra, la speranza ritorna. Ci basta seguire una stagione produttiva, per capire quanto la terra può restituirci, quando è amata e rispettata. Basta seguire la nostra mano piantare nella terra un piccolo seme. Essere il cambiamento.
Trasformiamo il diritto alla libera circolazione dei semi in una battaglia sociale, in una battaglia per la dignità della vita.
Roberta Cucciari